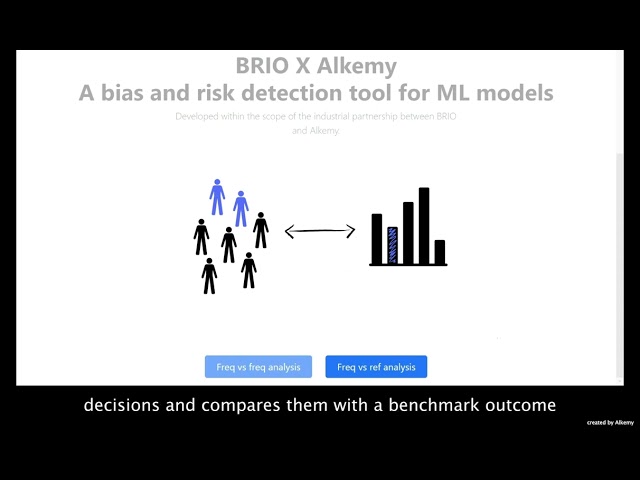22 aprile 2024
Ore 11:00-13:00.
Incontri e conferenze
Alfredo Ferrarin: Il modo simbolico d'espressione delle idee
Sala Rappresentanza del Roettorato, Via Festa del Perdono, 7, Milano